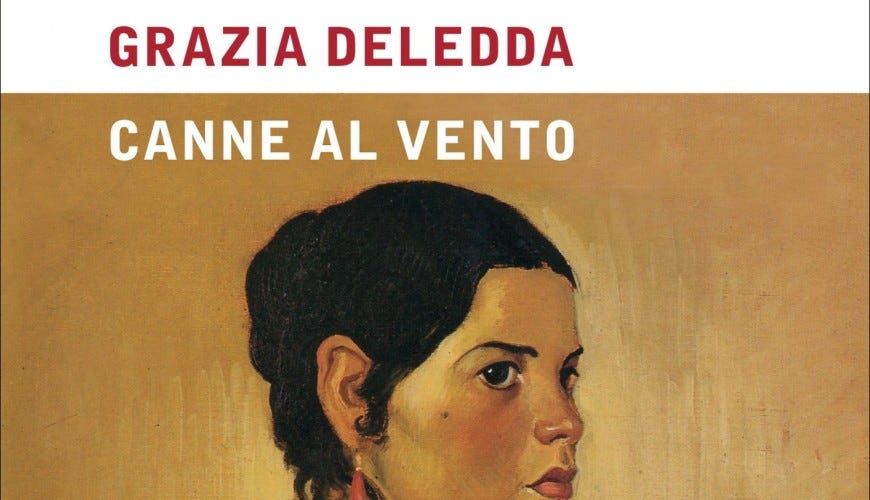Il mondo perduto di Canne al vento di Grazia Deledda – Mattoni Italiani 2/6
Analisi del capolavoro dell’unica autrice italiana a vincere il Premio Nobel per la Letteratura
Ho vissuto coi venti, coi boschi, colle montagne. Ho guardato per giorni, mesi ed anni il lento svolgersi delle nuvole sul cielo sardo. Ho mille e mille volte poggiato la testa ai tronchi degli alberi, alle pietre, alle rocce per ascoltare la voce delle foglie, ciò che dicevano gli uccelli, ciò che raccontava l’acqua corrente. Ho visto l’alba e il tramonto, il sorgere della luna nell’immensa solitudine delle montagne, ho ascoltato i canti, le musiche tradizionali e le fiabe e i discorsi del popolo. E così si è formata la mia arte, come una canzone, o un motivo che sgorga spontaneo dalle labbra di un poeta primitivo.
Grazia Deledda nel discorso preparato per Gavino Gabriel, compositore etnomusicologo e scrittore sardo (1881-1980) che nel 1933 si reca dalla scrittrice per registrarne la voce.
Grazia Deledda (1871, Nuoro - 1936, Roma) è stata l’unica donna italiana a vincere il Premio Nobel per la Letteratura nel 1927. Questo solo dato probabilmente ha fatto sì che tra i banchi di scuola il suo sia uno dei pochi nomi femminili a essere menzionato, anche se raramente approfondito, nei programmi antologici della nostra Letteratura. Troppo a lungo collocata nel filone regionalistico, Deledda è stata spesso ridotta a una declinazione locale (e provinciale) del realismo, tra le correnti del Verismo e del Decadentismo.
La scrittrice sarda si guadagnò tale reputazione dalla scelta, tutt’altro che miope, di dedicare la sua intera opera – con pochissime eccezioni – alla terra natìa, da cui si allontanò solo fisicamente, per trasferirsi prima a Cagliari e poi a Roma (considerata da lei la “Gerusalemme delle arti”) per perseguire la carriera di scrittrice, progetto impossibile da realizzare nella Sardegna del suo tempo, in cui alle donne era preclusa la sfera intellettuale.
Deledda stessa, infatti, smise di andare a scuola dopo la quarta elementare, in linea con la tradizione dell’epoca che garantiva alle donne soltanto l’istruzione minima per prendersi cura della casa e della famiglia, il “destino biologico” della femminilità.
Deledda, però, è un’eccezione. Nasce in una casa benestante della provincia, “tra il patriarcale e il selvaggio, che non appartiene né alla borghesia né al popolo né alla nobiltà” e fa “casta a sé”1. Il padre, infatti, è un proprietario terriero, laureato in legge, impegnato nel commercio e nell’agricoltura con profondi interessi intellettuali (aveva anche una tipografia e amava la poesia). Non vivono nel lusso e sono ancorati alla tradizione, ma risultano abbastanza vicini alla modernità per ispirare nella giovane Deledda un desiderio di emancipazione e progresso.
Quinta di sette figli, già da piccola la sua immaginazione si accende ascoltando i racconti popolari e le leggende della tradizione orale sarda, impastata di religiosità, folklore ed elementi fantastici. Curiosa e affamata di storie, si appassiona ai classici che trova nella ricca biblioteca paterna, e insiste per proseguire gli studi da autodidatta, imparando prima con un precettore e poi da sé l’italiano (la lingua natìa era il sardo), il francese e il latino.
Inizia a scrivere da adolescente e, in segreto, manda autonomamente racconti e novelle alle maggiori riviste italiane presenti “sul continente”, come viene chiamata la penisola italiana al di fuori della Sardegna. La sicurezza in se stessa e nelle sue doti da scrittrice, manifestatesi precocemente, sono pienamente giustificate: sulla rivista L’ultima moda vengono pubblicati i racconti Sangue Sardo e Remigia Helder. Ma è Stella d’Oriente il romanzo a puntate, uscito sul quotidiano L’avvenire della Sardegna, che avvia la carriera di Deledda, insieme alla pubblicazione di Nell’azzurro, un libro di novelle per l’infanzia e, più tardi, a 21 anni, Fior di Sardegna. La scrittrice lavora instancabilmente, consolidando la collaborazione con riviste di prestigio per ogni intellettuale italiano dell’epoca – da Nuova Antologia a Illustrazione Italiana, dal Corriere della Sera a La Lettura – e costruendosi un nome a livello nazionale (tra i primi letterati a recensire i suoi lavori c’è anche Luigi Capuana che la elogia per La via del male del 1896).
Deledda, però, non viene appoggiata dalla propria famiglia, in particolare dalle zie che reputano la carriera da scrittrice assolutamente sconveniente e immorale. Le frustrazioni del contesto d’origine, arretrato e bigotto, emergono chiaramente nella sua autobiografia postuma, Cosima (1937):
Sogno un giorno di poter diradare con un mite raggio le foschie ombrose dei nostri boschi, narrare intera la vita e le passioni del mio popolo, così diverso dagli altri, così vilipeso e dimenticato e perciò più misero nella sua fiera primitiva ignoranza.
Anche i suoi compatrioti la ostracizzano, risentiti che l’autrice si ispiri a vicende e personaggi reali per imbastire le sue trame. Le stesse dame Pintor, protagoniste di Canne al vento, si basano su un vero gruppo di sorelle, originarie di Galtellì, paese in cui Deledda era solita recarsi in villeggiatura da giovane. Viene accusata quindi di diffondere menzogne e calunnie, dipingendo la Sardegna come una terra retrograda e “oscura”. Certamente la sua Sardegna è aspra, antica, primordiale, ma pur sempre amatissima e ritratta con una devozione religiosa. Paradossalmente, proprio dai suoi abitanti, Deledda non è compresa, anche per via del suo modo di vivere decisamente anticonvenzionale e “rivoluzionario”.

Il desiderio di trovare, quindi, un ambiente più favorevole allo sviluppo delle sue ambizioni, congiunto alle crescenti difficoltà familiari – la dipendenza del fratello Santus e vari lutti che si susseguono – la spingono a trasferirsi nella capitale. Qui Deledda, insieme al marito, Palmiro Madesani, conosciuto precedentemente a Cagliari, si afferma come scrittrice internazionale. Lo stesso Palmiro, un funzionario ministeriale, lascia il lavoro per diventare il suo agente letterario, assistendo e seguendo la moglie nella sua progressiva crescita artistica. Una coppia decisamente anomala e moderna per l’epoca. Il loro sodalizio professionale e sentimentale, da cui nacquero due figli, viene deriso e sbeffeggiato, nonostante il successo della scrittrice. Pirandello, in particolare, la prende di mira, paragonandola a “una brava massaia sarda”, e dedicando a Deledda e Madesani il romanzo satirico Suo marito, basato proprio sull’inversione dei ruoli di genere. Si dice anche che apostrofasse Madesani con il nome di “Grazio Deleddo”.
L’autrice non si fa comunque ostacolare dagli stereotipi e dall’astio dei suoi contemporanei, e a Roma pubblica il meglio della sua produzione artistica: Elias Portolu (1903), Cenere (1904), da cui viene anche tratto un film con Eleonora Duse, L’edera (1908) e Canne al vento (1913), il suo capolavoro.
All’inizio del secolo Deledda è una scrittrice matura che intrattiene rapporti di corrispondenza con il meglio dell’intellighenzia internazionale, attenta alle novità e alle tendenze del mercato, un’imprenditrice tutt’altro che chiusa nel suo mondo arcaico e primitivo, come purtroppo è stato erroneamente creduto. Lo stesso conferimento del Nobel è indice di un’abilità notevole nelle pubbliche relazioni – i Premi non si basano solo sul merito ma anche sulla capacità di farsi conoscere e apprezzare dai propri pari – e le motivazioni che hanno decretato la vittoria di Deledda, a coronamento della propria carriera, parlano chiaro:
“Per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita quale è nella sua appartata isola natale, e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano”.
L’esperienza sarda di Deledda diventa, quindi, non un limite ma un merito: la volontà dell’autrice è sempre stata quella di rappresentare in maniera autentica, e non stereotipata, la sua terra, illuminandola senza edulcorare una realtà a volte barbara, gretta e miserabile, a volte sublime, immortale e tragica. Infatti, al fondo delle storie raccontate, ci sono le stesse verità universali condivise da tutta la letteratura: la paura, la perdita, il dolore, la ricerca inquieta di un destino superiore, gli errori e l’espiazione, l’amore e l’odio come forze annichilenti e impietose.
Non stupisce, pertanto, che da queste contraddizioni, emerga anche un ritratto critico contraddittorio, sia di grande interprete del travaglio morale dell’umanità (come il critico Momigliano) sia come portatrice di sentimenti conservatori e antimoderni:
Chi vorrà cercare aspetti veristi in Grazia Deledda li troverà, così come reperirà ciò che desidera chiunque vorrà scrutare in lei la femminista, la decadente, la romantica, la naturalista, la romanziera rosa, la politica, e persino (…) la Grazia Deledda cattolica.
Salvatore Bulla, Grazia Deledda. Prospettive del religioso per una lettura critica
Qual è il mistero, allora, dietro la scrittrice? Scopriamolo analizzando la sua opera più famosa, Canne al vento, in cui ritroveremo tutti i grandi conflitti esistenziali della sua bibliografia.
Guarda qui anche la live di discussione e commento della seconda tappa con Martina Asero. O ascolta l’episodio in formato podcast qui.